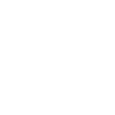Ref. Gb 7,1-7; Sal 146; 1Cor 9,16-23; Mc 1,29-39
La liturgia affronta il drammatico tema del dolore e del suo perché. Fa da introduzione il pietoso lamento di Giobbe che, afflitto dalla malattia, considera la sua vita un “soffio”, una parabola discendente “senza speranza”. Egli interroga Dio, lo sfida a dirgli il perché di tanta sofferenza, Giobbe sente che se essa fosse una punizione sarebbe immeritata, poiché ha sempre agito da uomo giusto, timorato di Dio e “devoto”.
Il mistero del dolore
Alla fine del libro Dio si presenterà a Giobbe in un turbine di vento mostrando tutta la sua potenza e l’insondabile sapienza che ha profuso nella creazione. Può l’uomo comprenderla del tutto o imitare Dio, o penetrare nella sua infinita sapienza fino a esplorarne la profondità? Giobbe intende, tace e riconosce la sua inferiorità di creatura di fronte al Creatore: “E’ vero senza nulla sapere ho detto cose troppo superiori a me che io non comprendo …perciò mi ricredo e mi pento”. Il perché del dolore rimane senza risposta, ma possiamo trarre dal brano proposto diverse considerazioni. Innanzitutto la pena inferta a Giobbe parte dalla fiducia che Dio ripone in lui: Dio ha “fede” in Giobbe e sa che non lo tradirà.
C’è poi lo straordinario cammino spirituale che Giobbe compie sotto la spinta della malattia e del dolore. Egli era sì uomo giusto e devoto, ma Dio rimaneva lontano dalla sua vita interiore. Attanagliato dalla sofferenza, invece, Giobbe grida a Dio, eleva il suo amaro lamento, la sua aspra recriminazione e interroga Dio sul perché di tutto questo, lo sfida a rispondere e gli parla come da uomo ad uomo. La sua devozione si è trasformata in un dialogo appassionato, in una preghiera che travalica i canoni delle formule e dei riti e vola libera dalla sua anima al cuore di Dio.
Dio non vuole la sofferenza
Nemmeno Gesù risponde al perché della malattia e della sofferenza, ma parteciperà ad essa intimamente mediante la passione e la croce. Lo vediamo, durante la sua missione terrena, chinarsi sui malati, guarirli, offrire gesti e parole di speranza e di sollievo, per farci comprendere che Dio non vuole la sofferenza ma la gioia delle sue creature e ad esse chiede fede e fiducia, perché verrà tempo – ed è l’eternità – in cui ogni lacrima sarà asciugata e ogni male troverà definitivamente termine. E allora questo non è il tempo di interrogare Dio ma è il tempo della fede, il tempo insostituibile della sequela e della preghiera.
Qualunque sia l’origine della sofferenza, certo è che essa diventa motivazione privilegiata per cercare Dio, per parlargli, per chiedergli di guarire; sotto la sua angosciante azione la preghiera si trasforma in un dialogo struggente, in un incontro che si eleva al di là delle frasi fatte e stantie nelle quali spesso ci rifugiamo.
Quando la preghiera diventa dialogo
Non solo la sofferenza, ma soprattutto il desiderio di Dio, dà origine alla preghiera spontanea e Gesù ce ne dà un esempio luminoso: “Al mattino presto si alzò quand’era ancora buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto, e là, pregava”. L’ora antelucana, “l’uscire” e il “ritirarsi” di Gesù ci mostrano che la preghiera personale muove dal desiderio di incontrare di Dio, di avere con Lui un colloquio intimo, al riparo da sguardi e orecchi indiscreti quasi un convegno d’amore.
E’ necessario perciò “uscire” da noi stessi, liberarsi da ogni vincolo e andare dove c’è silenzio, in un luogo segreto che a volte si chiama cuore e là ritirarsi. Gesù non porta con sé alcun libro o manuale, non si va da un amico per leggere un libro, ma per parlare con lui e confidarsi, esporgli pensieri e sentimenti, esperienze vissute e desideri, per confrontarsi con lui, ascoltarne il parere e seguirne il consiglio. Solo così Dio sarà l’amico, l’unico di cui abbiamo bisogno, perché la vita si colori di speranza e la sofferenza sia accolta come prova che saggia la nostra fede e tiene viva l’attesa di Colui che tutto può, tutto governa con sapienza e tutto ama di ciò che ha creato.
L.R.