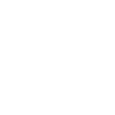Rif.: Am 6, 1.4-7; Sal 145/146, 6-10; 1Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Si dice che s. Luca, oltre che medico, sia stato anche pittore e non c’è dubbio che, se così fosse, per dipingere il brano del Vangelo odierno avrebbe usato le stesse luci ed ombre del Caravaggio. Il brano si divide in tre scene, nella prima siamo abbagliati dalle luci che emergono dal salone lussuoso, dalle sete rilucenti degli abiti, dai colori del cibo succulento, dai gioielli indossati dal ricco epulone. Nella seconda si stagliano le ombre che avvolgono il povero Lazzaro, affamato e sofferente, circondato dai cani che leccano le sue ferite. Queste due scene sono nettamente divise da una porta … aperta! Una falsa apertura che è in realtà frattura profonda: quella che si determina a volte tra due esseri umani e che è dovuta all’indifferenza, alla cura di se stessi, alla mai sazia ingordigia di avere di più e di godere al massimo di quello che si ha. Gli occhi del ricco epulone non si volgono mai verso Lazzaro, le sue orecchie sono sorde al lamento dell’altro, i suoi occhi non vedono le sofferenze e il suo cuore non duole per quel povero alla sua porta. Vi è infine la terza scena, qui la situazione si è capovolta: la figura di Lazzaro, con accanto Abramo, risplende di gloria là dove gli angeli lo hanno portato alla sua morte. Giù, avvolto dalle tenebre, dove solo una fiamma divoratrice arde, c’è l’epulone sofferente: egli chiede che Lazzaro lo sollevi e gli dia almeno una goccia d’acqua. Non è possibile: un abisso li divide e questo abisso è simile a quella porta aperta che l’epulone non ha mai varcato per portare sollievo, per interessarsi a Lazzaro, porta che ora assume il simbolo di un’occasione perduta, di un cammino di pietà mai intrapreso che ora lo condanna ad una eterna sofferenza! Il ricco allora invoca misericordia per i fratelli perché siano avvisati affinché si ravvedano e che, almeno a loro, sia risparmiato un così triste destino. Il Vangelo si chiude con una drammatica affermazione: “(no, perché), essi non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”. Parole forti che interpellano la fede di ciascuno e che si riferiscono chiaramente a Gesù, morto e risorto per la nostra salvezza. Quanto il grande ed ineffabile mistero della redenzione influisce nella nostra vita? Come modifica il nostro modo di essere, di pensare, di comportarci? Le nostre azioni ed i nostri sentimenti si ispirano a Cristo o alle nostre voglie smodate di apparire, di avere, di possedere a tutti i costi? Quanto ed in che modo Cristo segna il nostro rapporto con i sofferenti, i poveri, i bisognosi? Ci lasciamo coinvolgere dal pensiero dell’eternità cui stiamo andando incontro o siamo come “gli spensierati di Sion che canterellano al suono dell’arpa” di cui ci parla il profeta Amos? Eppure a loro Dio dirige il suo inesorabile “guai” che equivale alla minaccia di un inesorabile castigo. Alla luce dell’insegnamento evangelico maggior valore acquistano le raccomandazioni di Paolo al suo pupillo Timoteo: “Tu, uomo di Dio, tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua professione di fede”.
Anche noi come Timoteo ogni domenica professiamo la nostra fede non solo in Dio ma anche nella: “resurrezione dai morti e la vita del mondo che verrà” e con ciò non solo dichiariamo la nostra fede, ma ci impegniamo a vivere in modo coerente ad essa per giungere alla vita eterna. Il Credo non è solo una formula, ma è un incondizionato affidamento a Dio, un programma di vita che ci vincola a vivere la vita che Dio ci dona, secondo la sua volontà che è salvezza e gioia infinita per ogni sua creatura.
L.R
Fot. Amber Kipp/Unsplash.com