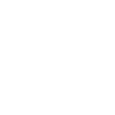Rif.: Sir 35, 12-18; Sal 33; 2Tim 4, 6-8.16-18; Lc 18, 9-14
Se le letture della scorsa settimana rispondevano alla domanda del “quando” pregare, questa volta ci indicano “come” pregare. La risposta è contenuta in tutta la vita terrena di Gesù che si pone ad esempio di preghiera non solo costante, ma “umile”. L’uomo Gesù infatti, spogliatosi della sua maestà divina, diventa “creatura” che cerca e ha bisogno del “Creatore” come un affamato del pane. In ogni occasione vediamo Gesù raccolto in preghiera, cercare Dio e dirgli, nella sua debolezza di uomo, il ringraziamento e la lode, ma anche la paura e l’angoscia, il bisogno di aiuto e di coraggio per rimettersi completamente alla volontà di Dio. Non solo con la propria vita ma anche con il suo insegnamento Gesù ci raccomanda l’umiltà nella preghiera ed è oggi la volta della parabola del fariseo e del pubblicano. Due uomini si trovano di fronte a Dio: il primo sicuro di sé, della propria moralità, del proprio modo di agire, ricco di presunzione, buon conoscitore della Legge che osserva scrupolosamente, ricco soprattutto di disprezzo verso gli altri che considera inferiori e soprattutto peccatori indegni. Non si accorge però che così facendo egli si sostituisce a Dio in un giudizio senza appello che assolve se stesso e condanna gli altri, la sua non è una preghiera, ma un’auto celebrazione che lo eleva ai propri occhi e purtroppo lo nasconde agli occhi di Dio. Le sue parole sono fiato sprecato perché non riescono ad elevarsi mancando di spinta interiore, egli non ha nulla da chiedere, nulla da rimproverarsi, nulla per cui ringraziare non a caso il Vangelo sottolinea che il fariseo pregava “tra sé”. L’altro, invece, il pubblicano che è rimasto sulla soglia del Tempio, prostrato nella propria vergogna, consapevole di aver bisogno di Dio e del suo perdono, ma di esserne totalmente indegno non fa altro che ripetere: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. La sua è la preghiera che sale a Dio perché di Dio ha bisogno quell’uomo che se ne riconosce indegno, che non osa alzare lo sguardo ma eleva il proprio cuore e lo mostra a Dio grondante di pena e di pentimento. La sua è la preghiera del “povero” di cui parla Gesù nelle beatitudini, la preghiera di chi si affida a Dio: la sua più che una preghiera è il gemito di chi non osa alzare lo sguardo e si batte il petto, quasi a scardinare il carico di peccati che si porta dentro e poi solo quelle poche parole: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Non osa altro se non chiedere pietà per quei peccati che affollano i ricordi, pietà per sé e per il suo disperato bisogno di Dio e chi se non Dio può aiutarlo? Questi, aggiunge Gesù, se ne tornò giustificato: Dio si era chinato verso di lui attratto da quel lamento soffocato, commosso da quel pentimento senza nome, vinto da chi si era rifugiato in Lui.
Il pubblicano ci dice che la preghiera è un cammino che parte dalla triste realtà del nostro peccato e attraversa le strade misteriose del cuore prima di giungere nella Verità di Dio che ama e che salva. Dal cuore dell’uomo che si rivolge a Dio, e non dalle parole, la preghiera trae la sua forza e dall’umiltà il suo vigore.
A te che sei il Santo, elevo il mio grido che invoca pietà,
a te che sei il Creatore, dico la mia povertà,
a te che dall’alto scruti nei cuori mostro la mia indegnità
perché tu legga la mia anima e ne abbia compassione.
Da te venga l’aiuto di cui ho bisogno,
il perdono che anelo, l’amore che desidero,
la forza che mi manca …
O Dio, abbi pietà di me peccatore e
guarda anche a me come al pubblicano al tempio ….
L.R.