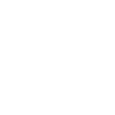Parlare di mons. Jacques Mourad arcivescovo di Homs non è solo illustrarne la biografia, che si trova, peraltro, già nell’invito. Mourad è un monaco d’Oriente e, da monaco, la sua storia vuol essere piccola. Purtroppo varie Chiese cattoliche orientali hanno perso il monachesimo, ma padre Jacques ha partecipato alla rinascita monastica insieme a padre Paolo Dall’Oglio.
Oggi non si può non pensare alla sua umile e grande Chiesa, la più vicina al mondo ebraico-aramaico di Gesù e della prima predicazione, per lingua, liturgia, spiritualità. Il suo patrimonio teologico e letterario è immenso (basta il nome di Efrem il siro), in parte ancora da valorizzare. È una Chiesa che ha vissuto nell’umiltà e nella sofferenza. La famiglia Mourad da parte paterna viene da Mardin e dal Tur Abdin, per più di un millennio rifugio dei siriaci, perseguitati dai bizantini, dagli arabi e infine dai turchi. Le minoranze nel Mediterraneo – insegna Fernand Braudel – si sono rifugiate tra i monti, così è accaduto alla Chiesa maronita, a cui appartiene la madre del nostro Premiato.
Una Chiesa, quella siriaca, senza mai potere politico, la cui forza è un popolo fedele, povero, attorno a una costellazione di monasteri. Lo si vede visitando il Tur Abdin, la Montagna dei Servitori di Dio: un’ottantina di monasteri, alcuni in rovina, non abitati, fortezze dalla porta stretta, accanto ai villaggi. Li visitai, per la prima volta, nel 1984: erano in rovina, ma oggi l’amore degli emigrati li ha restaurati.
La famiglia Mourad lasciò la terra ancestrale come altre famiglie. Nel 1915, gli ottomani scatenarono la caccia ai cristiani. I siriaci, divisi tra cattolici e ortodossi, furono colpiti. In qualche monastero ci sono ancora i segni di questa persecuzione: pallottole sui muri o, come si vede ancora a Mardin, un’accettata sulla porta della chiesa armeno-cattolica. Fu la strage: una pulizia etnica crudele. Per i siriaci è Seyfo, l’ora della spada. Un popolo di poveri e di martiri. Il piccolo Jacques sentiva storie dolorose raccontate da una zia. Molti erano uccisi, perché rifiutavano di divenire musulmani. Pochi restano oggi, ma quella terra è benedetta dalla preghiera dei monaci, irrigata dal martirio. Lì si percepisce quello che la sapienza indiana insegnava: “Inginocchiati dove gli altri si sono inginocchiati perché Iddio è presente dove tutti hanno pregato”.
La famiglia Mourad, dopo tanto vagare, approdò ad Aleppo, dolce città siriana, oggi martirizzata da più di dieci anni di guerra, che ancora attende due vescovi, il siriaco Mar Gregorios Ibrahim e l’ortodosso Boulos Yazigi, rapiti nel 2016. Il mondo, in cui Jacques cresce e matura la sua vocazione, è un intreccio di unità tra cristiani e di divisioni: la mamma maronita, il padre, molto credente, siro-ortodosso divenuto cattolico per i problemi con il parroco e via dicendo. Diceva, a proposito dei cattolici orientali, il grande Mons. Edelby di Aleppo: “noi siamo figli di divorziati!”. Padre Jacques è prete siro-cattolico di un popolo, schiacciato come i siriani dal regime tirannico e brutale degli Assad, verso cui il timore del radicalismo islamico spingeva molti cristiani. Non però mons. Mourad.
Lui è un monaco, affascinato dall’esperienza monastica di Mar Mousa, monastero del VI secolo dedicato a Mosè l’etiope, segno di scambi tra monaci non calcedonesi. Paolo Dall’Oglio, gesuita romano, con l’irrequietezza creativa della sua generazione, lo restaura. La vita esuberante di Paolo, che ho conosciuto bene, si spende per l’unità cristiana, il dialogo con l’islam, tanto che chiama la Comunità, Al Khalil, in arabo l’Amico, Abramo, “patriarca noster et pater omniun credentium”. La sua spiritualità, cui padre Jacques aderisce, deve molto a Charles de Foucauld e alle suggestioni di Louis Massignon sul rapporto abramitico con l’islam. Mourad fatica nel dialogo con l’islam, finché s’immerge nella Nostra Aetate e trova la via dell’amicizia con i musulmani a partire dalla povera gente. I volti dell’islam, da lui toccati, dei ricordi familiari, jihadista al tempo del rapimento, della povera gente, dei sunniti sotto la dittatura, sono diversi. Il nostro Premiato è uomo semplice, ma conosce la complessità.
Il monaco diventa pastore a Qaryatayn: ravviva i siriaci e l’onda arriva agli altri cristiani e ai musulmani. Conosco parecchi giovani della parrocchia, fuggiti per la pressione islamista, arrivati a Roma con i corridoi umanitari di Sant’Egidio: si vede in loro cosa significhi aver avuto come pastore padre Mourad, per cui la liturgia e la Bibbia sono il cuore, per cui non si accumula denaro per sé, ma si vive per il popolo e si crea una comunità. La loro fede, dopo tante traversie, è la vera laudatio al Nostro.
Rapito dai jihadisti, è imprigionato e colpito nel corpo, sospettato in quanto nasara, cristiano, interrogato, rischia più volte la morte. Tratta con individui da niente nel frattempo “diventati uomini potenti” con il terrorismo: è l’onnipotenza dei jihadisti. Mourad vive nello Stato islamico realizzato. Prega, ma dubita di uscirne. Racconta le sofferenze in Un monaco in ostaggio, senza odio e vittimismo. Ai giovani musulmani che dicevano: “Non c’è niente che possa rimpiazzare le armi”. Risponde da pacifico. Vive l’ora delle tenebre della Siria, durata tanto, troppo.
Il monaco sperimenta la forza debole della preghiera: “In prigione, nel bel mezzo della mia angoscia, io ne ho fatto esperienza. È grazie alla preghiera mia e di tutti quelli che hanno pregato per me, che sono stato salvato”. Un imam gli dice: “considera questa prigionia come un ritiro!”. Parecchie le proposte di conversione. Il nostro premiato porta sul corpo i segni di quella dura esperienza. Finché non giunge la mana, il dono o perdono, del califfo Al Baghdadi, perché i suoi cristiani non hanno impugnato le armi. Lui e i parrocchiani rapiti possono tornare al villaggio. Era la scelta dell’essere cristiani che li ha salvati.
Tornato in Italia per un periodo, padre Jacques mi disse che voleva rientrare in Siria per vivere il tempo difficile del suo popolo. Sapevo che era nella lista del regime a causa della sua libertà di parola e temetti per lui. Così lo sconsigliai. Lui è un mite, ma non c’è peggiore testardaggine di quella dei miti. Rientrò nel paese, nonostante i rischi che avrebbe dovuto affrontare con il potere e la guerra in corso. Per lui i cristiani non dovevano lasciare le terre ancestrali, non per fedeltà archeologica, ma per una missione. Anche quella di affermare il pluralismo di fronte a un islam sempre più solo con se stesso con tutti i rischi conseguenti. Oggi, come vescovo, partecipa di più a questa missione: non custodire un museo, ma costruire la Chiesa. Difficoltà ci sono, ma è un pastore felice del suo popolo e dei suoi preti. Violenza e dolore non l’hanno annientato. È un uomo che sa gioire.
Mons. Mourad merita questo Premio, intitolato a un papa che, vecchio e malatissimo, disse sorprendendo tutti: “tutto può cambiare. Dipende anche da te”. Giovanni Paolo II non si è fermato di fronte al muro dell’impossibile, ma ha pregato, sperato, lottato con fede fino alla fine. Per lui il cristiano era chiamato ad essere forte e a non aver paura. Scrive Mourad: “Siamo ancora convinti della forza della preghiera? In prigione nel mezzo della mia angoscia, io ne ho fatto esperienza… Commosso della nostra preghiera Dio fa miracoli. Ma crediamo ancora ai miracoli?”. Speriamo nel miracolo della pace, della resurrezione di una Chiesa, del vivere insieme tra diversi come fratelli.
Prof. Andrea Riccardi
(Cerimonia di consegna del Premio San Giovanni Paolo II a mons. Jacques Mourad Sala Regia del Palazzo Apostolico, 18 ottobre 2025).